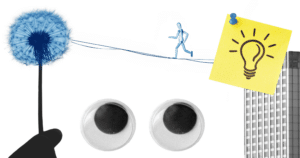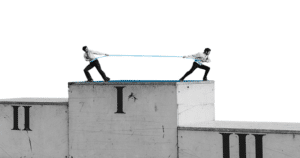"Perché un coach deve andare a Venezia?" Lezioni di Coaching dall'arte contemporanea.
Nel mio nuovo ruolo di responsabilità scientifica, decido di visitare la Biennale di Venezia con gli occhiali di Coach e, quindi, con una domanda: “Cosa può apprendere un coach dall’arte contemporanea?”. Sul Freccia Rossa, che mi porta verso i Giardini della Biennale, trovo la rivista “La Freccia”. Dall’articolo di Sandra Gesualdi, apprendo che Christine Macel, curatrice della 57ma Esposizione Internazionale d’Arte Viva Arte Viva non abbia voluto dare nessun fil rouge all’esposizione ma predisporre un allestimento pullulante di energia, di individualità soggettive, di identità nazionali; un progetto che mettesse in rilievo la diversità dei singoli artisti e la complessità delle espressioni contemporanee. Viva Arte Viva (che come titolo campeggia in molti spazi dell’esposizione) nasce proprio dall’idea di dare voce, libertà e responsabilità a ciascun artista presente. Questo è il senso dell’umanesimo artistico che caratterizza l’esperienza dell’esposizione. La diversità esistenziale degli artisti si esprime nella scelta delle forme d’arte e del punto di vista, nella disposizione degli oggetti e delle installazioni, nella eterogeneità degli spazi di conoscenza che si offrono all’osservatore. Subito mi viene in mente che noi coach abbiamo a che fare con “l’arte viva” dell’essere umano, cioè con la materia preziosa e viva delle persone.
“I nostri coachee rappresentano la vera “arte viva”. Tante opere d’arte della creazione, persone uniche e irripetibili, con limiti umani, ma anche con talenti nascosti da valorizzare”.
In questo è il senso neo-umanistico delle organizzazioni: in un’attenzione maggiore alla persona, al suo potenziale, alla sua creatività e diversità soggettiva, e anche nell’uso delle discipline e delle arti liberali per favorire la crescita e la rieducazione degli uomini d’azienda. Perciò il coaching s’inscrive a pieno titolo nella curvatura umanistica delle organizzazioni, e quindi può essere colto facilmente nelle metafore e nella retorica dell’arte.

Confermato questo pensiero, la mia prima sfida alla Biennale è quella di non cedere completamente al godimento estetico che mi procura la bellezza dei Giardini di Venezia o il piacere dell’esperienza cameratesca dell’escursione in compagnia. Non voglio neppure conformarmi all’atteggiamento “visito-tutto-velocemente-e-fotografo“, imperante tra i più del vernissage. Con un atto profondamente dadaista, in controtendenza rispetto alla fretta delle masse e agli assembramenti delle code, mi improvviso flâneur dei luoghi d’arte, e sosto immobile nei punti di osservazione che più catalizzano la mia attenzione percettiva. Mi isolo, talvolta, dalla piacevole compagnia, resto in silenzio, cerco di osservare i miei pensieri fino ad arrivare alla percezione dell’opera. Inaspettata, ma felicemente accolta, mi giunge una seconda illuminazione:
“Per entrare in relazione con il coachee, come con una stravagante installazione contemporanea, occorre innanzitutto disporsi in uno stato d’ascolto, distaccarsi dai pensieri, respirare e rilassarsi, fare silenzio e spazio dentro sé”.
Infatti, abbiamo bisogno di un po’ di raccoglimento interiore per disporci all’accoglimento esteriore. Fare spazio dentro di sé, per concedere spazio di relazione e tempo di ascolto all’Altro. Maurice Merleau-Ponty, nel libro Phénoménologie de la perception, sosteneva che “lo spazio è esistenziale e che l’esistenza è spaziale“. E questo vale tanto per il corpo fisico che per il vissuto conversazionale.
La mia seconda sfida alla Biennale, ora, è quella di capire le opere contemporanee. Mi è sempre piaciuta l’arte visiva del Novecento. Oscillo gioiosamente tra il surrealismo di Magritte e la metafisica di de Chirico. Sono un appassionato di pittura e…., in realtà, non riesco ad apprezzare molte espressioni dell’arte contemporanea – che in alcuni casi trovo ostentatamente eccessive, quasi fossero fatte per il solo gusto di provocare e di apparire. Consapevole di ciò, mi dico che qualcosa di buono troverò anche in questa esperienza. Leonardo Rotatori, presidente della i-AMF (Italian Art Motherboard Foundation) con cui SCOA – The School of Coaching è in partnership per la Biennale, è la nostra autorevole guida e ci introduce alla visita dei padiglioni nazionali, predisponendo la nostra attenzione alla cultura artistica rappresentata in ciascuno di loro.

Così mi avvicino all’esperienza dei padiglioni nazionali, con l’atteggiamento di ascolto dell’identità culturale, dei valori, dell’estetica di quei luoghi geografici e di quel gruppo di artisti, cercando di comprendere anche le loro differenti poetiche soggettive. Entro nei padiglioni, ma l’arte contemporanea non mi giunge subito, abituato come sono ad approdare scientificamente alla conoscenza. Per apprezzare, prima devo capire. E le mie categorie, i miei modelli, la mia conoscenza vacillano di fronte all’apparente “illeggibilità” di alcune opere e installazioni. La mia amica artista e collega coach, Anja Puntari, mi rassicura e mi fa riflettere: capisco che l’arte contemporanea non arriva subito, che non si manifesta con un significato chiaro e immediato, comprensibile tout court dalla mia parte razionale. Piuttosto mi catapulta in un mondo di emozioni e di esperienze che lasciano un segno, a volte anche non comprensibile consciamente. Emerge un altro pensiero:
“Nella relazione con il proprio cliente, ogni coach deve essere educato all’ascolto e all’emozionalità, ossia deve ascoltare l’Altro con il cuore e con la mente, sempre integrati tra loro”.
Mi rendo conto che le mie pre-immagini, i miei pensieri e i miei pregiudizi estetici mi impediscono di aprirmi pienamente all’emozione dell’incontro con l’opera. Di fronte a questa ennesima installazione contemporanea che mi appare di fronte, sono determinato, però, a limitare l’influenza delle mie credenze su quello che sto vedendo, ascoltando e toccando. Cerco di guardare l’opera, ma continuo a vedere il riflesso del mio volto su di essa. Mi torna in mente Magritte, con il “problema della finestra”, a rammentarmi che noi vediamo solo la nostra rappresentazione mentale della realtà. Lotto con questa idea. Facendo appello all’epochè fenomenologica, “sospendo il mio giudizio“, ossia cerco di mettere tra parentesi quello che penso io, le mie reazioni e risonanze personali, e provo a vedere cosa c’è dall’altra parte di me. Ecco, confermo un altro apprendimento sul coaching.
“Come nell’arte contemporanea, anche nel coaching, per entrare in relazione con il cliente, bisogna, innanzitutto, rispettare il suo modo d’essere, il suo stile personale, i suoi valori e le sue credenze, aprendosi con flessibilità a modi diversi di vedere la realtà e di vivere la vita”.
E quand’anche sentissimo il peso dei nostri giudizi o delle nostre emozioni, dovremmo imparare a discernere cosa appartiene a noi e cosa viene dall’altro.
Da “uomo di scienza” rievoco finalmente Carl Rogers, con la sua psicologia umanistica centrata sul Cliente, e mi ricompaiono alcune sue parole chiave che valgono anche nel coaching: a) congruenza del vissuto del terapeuta con quanto si comunica al cliente (vedi l’ascolto di sé del coach durante i colloqui e l’uso del feedback, quando è nell’interesse del coachee); b) accettazione incondizionata (non approvazione) dell’Altro (vedi la capacità di non giudicare del coach, il rispetto della diversità del coachee e la valorizzazione della sua capacità di auto-regolazione); e c) empatia col cliente (vedi capacità di ascoltare le emozioni del coachee e di non identificarsi con esse, in un sequestro emotivo del coach).
Nella mia camminata tra i padiglioni incontro un performer: immobile, di fronte a un alto e largo muro bianco, testa china in avanti, uno zaino nella mano sinistra, con un giubbetto catarifrangente rosso, con la scritta “Future?“. “Non capisco, ma mi adeguo”, diceva qualcuno. Allora, a qualche metro di distanza da lui, assumo la sua stessa posizione e mi apro all’ascolto, all’ascolto di quello che lui o che la sua performance vuole dire a me. Mi giungono sensazioni oppressive e di disturbo, prima, emozioni di ansia e tristezza, poi, e infine mi afferro alla metafora che mi porta i significati che aspettavo!

Contento di “aver trovato il metodo”, mi sposto e mi avvicino a dei giganteschi gomitoli coloratissimi, grandi quasi quanto un essere umano (“Sheila Hicks, “Scalata al di là dei terreni cromatici”, 2016-2017): ce ne sono tanti, tantissimi, tutti appoggiati ad un imponente muro interno del padiglione espositivo. Mi rimetto a un certa distanza, in silenzio, guardo, uso gli stessi schemi di prima ma… non sento, non mi emoziono e non capisco. Ci riprovo: una, due, tre volte… ma niente! Capisco una difficile verità: quello che ci aiuta a dialogare con un’opera non ci serve per “ascoltare” la successiva! In termini più scientifici potrebbe suonare come segue: “L’architettura plastica della mediazione sinaptica, costruita per percepire un oggetto fenomenico, non produce economie di percezione e di significazione rispetto a oggetti di forme differenti”. Ovvero: ogni conoscenza è situata, contestuale e personale. Di conseguenza:
“Ogni cliente è un complesso mondo a sé, con linguaggi, codici, e significati propri. Il coach ha l’obbligo (e il piacere), ogni volta, di fare la conoscenza del suo cliente e di imparare a riconoscere significanti (parole, gesti, esteriorità) e significati specifici, per poter offrire il suo accompagnamento professionale”.
Di opera e in opera (come di coachee in coachee), quello che come coach sto davvero imparando è di rendere plastica la mia cognizione, ossia: sto diventando più flessibile, più capace di adattarmi di volta in volta alle situazioni, sono sempre più in grado di accogliere la diversità, sto riuscendo, cioè, ad “apprendere ad apprendere“, e quindi a cambiarmi.
La mia prima giornata a Venezia sta volgendo al termine. Grato dell’esperienza fatta, mi dico un’ultima cosa: sono venuto con l’intenzione di “capire” l’arte contemporanea, ma me ne sto tornando con la conoscenza che ho fatto di me stesso, e con gli apprendimenti che ho maturato. Jacques Marie Émile Lacan, famoso psicoanalista studioso di arte, diceva:
«L’interpretazione di un’opera d’arte non è svelamento di verità, ma ricerca soggettiva di senso».
Così, allo stesso modo, possiamo dire che, come coach, le conversazioni che abbiamo con i nostri coachee ci aiutano a conoscere e, auspicabilmente, ad aiutare loro, ma certamente ci aiutano a conoscere di più noi stessi, e a crescere e ad affrontare diversamente il nostro stesso cammino di vita.
Emilio Rago, Ph.D.
Direttore Scientifico SCOA – The School of Coaching
Altri articoli correlati