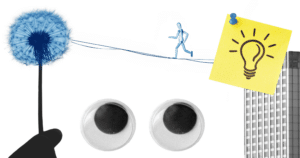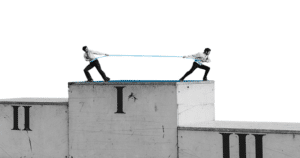Dall’elogio della disponibilità 24/7 alla valorizzazione delle pause. Intorno al mondo del lavoro si sta facendo sempre più sentire il dibattito riguardo a come l’ambiente e la cultura delle aziende debbano evolversi e la chiave di volta sembra possa trovarsi nello spostare il focus dal profitto a tutti i costi al rispetto a 360° delle persone.
Quando il lavoro diventa uno stile di vita
“Nobody has ever changed the world working 40 hours a day” scriveva in un suo tweet del 2018 Elon Musk.
Oltre a sembrare una predizione del messaggio che i dipendenti di Twitter avrebbero ricevuto da Musk stesso nel 2022, questa breve frase sintetizza l’atteggiamento che, in parte ancora oggi, ci si aspetta che le persone abbiano nei confronti del lavoro: un misto di competizione, ambizione e devozione che spinge a lavorare sempre di più, sempre più velocemente e in qualunque momento, notti e weekend inclusi.
Questa tendenza allo stacanovismo che si è consolidata negli ultimi decenni ha trasformato il mondo del lavoro in una gara sempre aperta in cui a vincere è chi non smette di lavorare mai. In anni più recenti abbiamo imparato a chiamarla hustle culture (hustle in inglese significa “attività febbrile, frenetica”) ed è figlia di una narrativa basata su tre pillar:
- chi si impegna sul lavoro fa carriera (carriera =soldi)
- avere soldi è sinonimo di avere successo
- il successo è la porta d’ingresso per essere felici (e invidiati).
Nonostante siano ormai evidenti le sue ombre, questa cultura è ancora molto sentita, tanto che, secondo lo studio Hustle culture and the implication on our workforce del 2020, il 45% dei lavoratori dichiara di terminare spesso le sue attività fuori dall’orario e, soprattutto, si dice sicuro che questo sia ben visto dai superiori.
Si tratta di una mentalità talmente radicata nei nostri atteggiamenti e nei nostri pensieri che, spesso involontariamente, la mettiamo in pratica anche fuori dal contesto lavorativo: a chi non è capitato di dire, dandosi un tono, frasi come “lavoro sempre”, “non ho un attimo libero”, “ci vorrebbe una vacanza”?
Si chiama hustle porn e consiste nella feticizzazione di uno stile di vita senza sosta. Essere impegnati (o dire di esserlo), sia sul piano professionale che su quello personale, è equiparabile a uno status symbol, qualcosa che facciamo perché vogliamo suscitare l’ammirazione nelle persone che ci circondano.
Dire di essere senza niente da fare ci farebbe passare per persone pigre o prive di brio. Essere impegnati, al contrario, ci fa sentire bravi, giusti e meritevoli.
Ma essere dei workaholic che prezzo ha? E soprattutto, alle aziende conviene davvero avere dei collaboratori che non si fermano mai?
Gli effetti della hustle culture sulla salute e sul lavoro
Forse in alcuni casi ci piacerebbe, ma dobbiamo arrenderci, non siamo macchine e lavorare sempre al 100% non è sostenibile sul medio-lungo periodo. Anzi, è addirittura controproducente.
Prima ancora di arrivare a valutare gli effetti che il never-ending work ha sulle persone, è necessario rompere un falso mito: non è vero che più si lavora più si ottiene. Uno studio dell’Università di Standford ha dimostrato come la produttività segua un principio economico, ovvero la legge dei rendimenti decrescenti. Questo significa che superata una certa soglia di stress, più si cerca di alzare il livello di produttività, meno soddisfacente sarà l’output finale. I dati dello studio, infatti, dimostrano che se per chi lavora tra le 30 e le 50 ore settimanali il grado di soddisfazione del lavoro svolto raggiunge il 60%, per chi ne lavora tra le 51 e le 70 si ferma al 55.6%.

Veniamo ora ai rischi che vanno oltre l’aspetto professionale, ma che toccano la sfera della salute mentale, fisica e delle relazioni personali: il Current Cardiology Reports del 2018 dimostra come le persone che lavorano più di 55 ore alla settimana siano maggiormente esposte ai rischi di malattie cardiovascolari (+17%) e infarti (+35%), mentre la World Health Organization (WHO) evidenzia la relazione tra eccessivo lavoro e casi di ansia e depressione. Inoltre, spesso chi lavora un numero notevolmente alto di ore trascura relazioni familiari, di amicizia o sentimentali e l’isolamento che ne consegue può contribuire a creare una spirale negativa di insoddisfazione e dipendenza dal lavoro, aumentando così il rischio di burnout.
E a sperimentarlo non sono stati in pochi: secondo uno studio di Deloitte, il 77% delle persone ha avuto delle esperienze di burnout legate alla vita lavorativa e il 42% ha pensato di cambiare lavoro a causa di un burnout. Nonostante i numeri già alti, complice la pandemia, del 2020 e 2021, tra il 2021 e il 2022 i casi di burnout sono ulteriormente cresciuti del 10% (STADA Health Report).
Questo malessere sul mondo del lavoro si è concretizzato, nel corso degli ultimi due anni, in due fenomeni globali che hanno scosso le aziende e le organizzazioni: le Great Resignation e il Quiet Quitting.
Gli effetti negativi della hustle culture sono quindi ormai evidenti e questo sta portando a un cambio di paradigma importante per il mondo del lavoro, in cui le logiche della competizione e dell’ambizione a ogni costo si stanno sgretolando.

Leggi anche:
Quiet Quitting. Work is not your life
Non lavorare di più, ma lavorare meglio
Mettere in discussione la hustle culture significa scardinare le certezze su cui il mondo del lavoro si è fondato per decenni.
Il primo passo che stiamo compiendo è ridefinire il concetto di successo: stiamo passando dall’identificare questo termine con il denaro accumulato e con le ore lavorate, all’intenderlo con una concezione più improntata al benessere sia fisico che mentale, al rispetto della vita personale e del work-life balance.
Si sta diffondendo sempre più l’idea che il successo sia di chi riesce a lavorare (ovviamente la maggior parte di noi ha bisogno dello stipendio) godendosi le pause, seguendo una passione extralavorativa, passando il tempo con la famiglia o coltivando progetti personali. Stiamo imparando a trattare il lavoro come un mezzo con cui raggiungere la serenità e non come il fine ultimo delle nostre giornate.
Per spiegare la trasformazione che stiamo vivendo possiamo dire che si sta verificando il passaggio dalla hustle culture alla break culture.
La definizione di break culture è stata data da Artis Rozentals, CEO di Desktime, in un articolo da lui scritto per Forbes, in cui spiega che il modo migliore per lavorare, sia in termini di efficienza che di salute mentale, è promuovere l’importanza dei momenti di riposo e della qualità delle ore lavorate al posto della quantità.
Lavorare meno, ma meglio, quindi.
La sostituzione progressiva della hustle culture con la break culture parte, come spesso accade alle rivoluzioni, dal basso, con un cambio di mindset da parte dei dipendenti che, come già si sta verificando, non sono più disposti a sottostare a determinate condizioni. Ma molta responsabilità in questo ce l’hanno anche le aziende, che ora hanno il compito di creare un ambiente più rispettoso delle necessità di ciascuno.
Rozentals identifica quattro aree di intervento (comunicazione interna, buon esempio, valorizzazione delle persone e attenzione ai segnali) che le aziende possono tradurre in quattro competenze su cui puntare:
- People management: sia nella comunicazione delle modalità operative che nella gestione delle scadenze e dei carichi di lavoro, è importante tenere presente il valore del tempo. L’organizzazione delle persone diventa più efficace se si incentiva un ritmo di lavoro più sano e si valorizzano le pause come momenti di ispirazione e team building.
- Time management: in questo momento, chi occupa i ruoli dirigenziali di un’organizzazione ha una grande sfida davanti, ovvero quella di settare il passo del cambiamento. Smettere di veicolare il messaggio per cui “più si sta al computer, più si produce” e sostituire la tendenza di far vedere che si rimane in ufficio fino a tardi con delle abitudini più salutari farà sentire tutti i collaboratori più a loro agio nell’abbracciare atteggiamenti che vanno contro la cultura della frenesia.
- Cooperazione: se la hustle culture si basa sul fatto che i dipendenti non facciano mai abbastanza, abbracciare la break culture significa anche riuscire a valorizzare chi lavora. Nel concreto questo si concretizza con un atteggiamento che mira a coinvolgere e far sentire apprezzate le persone, offrendo aiuto e rispettando le opinioni di tutti.
- Ascolto: sia tra colleghi che tra persone di livelli diversi dell’organigramma, prestare ascolto ai propri collaboratori può aiutare a capire l’origine di eventuali loro disagi e a prevenire o risolvere il malcontento (o, nelle situazioni più estreme, casi di burnout).
Gli ambienti lavorativi con cui siamo stati abituati a confrontarci stanno cambiando radicalmente e (finalmente) stiamo portando la cultura del lavoro tossico al suo tramonto: al centro dei contesti lavorativi non c’è più l’efficienza fine a se stessa ma la persona. In questo momento di evoluzione è importante però che ognuno si ponga le domande giuste per capire se si trova all’interno di una hustle culture e, se sì, che cosa si può fare per trasformare il contesto in cui si muove in luogo più sano.
Leggi anche:
Perché le persone lasciano il lavoro e cosa possono fare le aziende per evitarlo